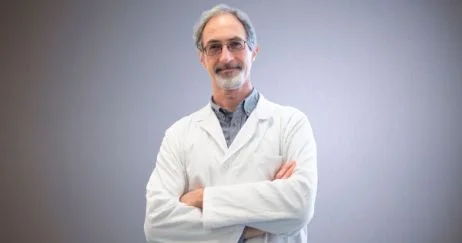Pancreatite autoimmune di tipo 1: uno studio apre nuove prospettive per il trattamento personalizzato
PUBBLICATO IL 10 OTTOBRE 2025
La pancreatite autoimmune di tipo 1 (in inglese, type 1 autoimmune pancreatitis, AIP-1) è un’infiammazione cronica del pancreas che prevale negli uomini con più di 60 anni d’età.
È la principale manifestazione della malattia IgG4-correlata, una patologia rara (in Italia si registrano circa 5-10 nuovi casi ogni 100.000 abitanti) che si presenta con masse simili a tumori ricche di plasmacellule (le cellule immunitarie che producono gli anticorpi) in diversi organi corporei.
Nell’AIP-1, fasi di recidiva, nelle quali ricorrono i sintomi della malattia e/o le lesioni degli organi evidenziate dalle immagini radiologiche, si alternano a fasi di remissione, nelle quali i sintomi e i segni radiologici scompaiono.
Le fasi di recidiva sono trattate con diversi cicli di glucocorticoidi, cioè farmaci ad azione antinfiammatoria e immunosoppressiva. Alla lunga, però, sia la malattia sia l’esposizione continua ai glucocorticoidi possono danneggiare ulteriormente diversi organi, aumentando il rischio dello sviluppo di diabete mellito e osteoporosi.
Per questo, ai pazienti che presentano fattori che predispongono a una forma più aggressiva della malattia, come elevati livelli di IgG4 (cioè immunoglobulina, un anticorpo, G4) nel sangue, o che presentano ricadute molto frequenti, si propone una terapia di mantenimento che impiega dosi più basse di glucocorticoidi oppure altri tipi di farmaci immunosoppressori.
Tuttavia, in circa il 25% dei pazienti i livelli di IgG4 rimangono alti anche quando i sintomi della malattia scompaiono e, in generale, le evidenze che supportano la terapia di mantenimento nei casi indicati di AIP-1 sono scarse.
Il dottor Marco Lanzillotta, internista immunologo presso l’Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, il dottor Emanuel Della Torre, reumatologo, allergologo e immunologo presso la stessa Unità e il professor Lorenzo Dagna, primario dell’Unità e associato di medicina interna presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, sono tra gli autori di uno studio i cui risultati, se confermati, aprono nuove prospettive per impiegare la terapia di mantenimento su misura dei pazienti con pancreatite autoimmune di tipo 1.
I risultati dello studio
Nello studio, che ha coinvolto 42 istituti di ricerca europei, i ricercatori hanno esaminato retrospettivamente 577 pazienti con AIP-1 che avevano avuto una remissione totale o parziale dei sintomi della malattia dopo il trattamento iniziale con gli immunosoppressori.
Di questi 577 pazienti:
- 255 avevano ricevuto una terapia di mantenimento con basse dosi di glucocorticoidi o altri farmaci immunosoppressori o antiinfiammatori;
- il resto dei pazienti non aveva ricevuto tale terapia.
Gli autori hanno innanzitutto valutato l’efficacia della terapia di mantenimento nel prevenire la recidiva (ricomparsa) della malattia dopo 3 e 5 anni dalla sua remissione, osservando che i casi di recidiva erano stati meno frequenti tra i pazienti sottoposti al mantenimento che tra i pazienti senza mantenimento.
Nello specifico, dopo 3 anni, la malattia era ricomparsa in circa il 22% dei pazienti che avevano ricevuto il mantenimento, contro circa il 35% dei pazienti non sottoposti a questa terapia. Dopo 5 anni, circa il 29% dei pazienti nel gruppo sottoposto al mantenimento aveva sperimentato una recidiva, contro il 46% dei pazienti nel gruppo senza mantenimento.
Quindi, in accordo con le poche evidenze precedenti, la terapia di mantenimento aveva efficacemente ridotto la frequenza delle recidive della malattia dopo 3 e 5 anni.
Terapia di mantenimento e rischio di recidiva
Gli autori si sono poi chiesti se i benefici della terapia di mantenimento fossero uguali per tutti i pazienti con AIP-1, sia per quelli a basso sia per quelli ad alto rischio di recidiva.
Allo scopo, hanno utilizzato un modello statistico basato su fattori prognostici (fattori, cioè, che aiutano a prevedere l’andamento della malattia) derivati dalla letteratura scientifica. In particolare, hanno integrato:
- fattori noti per proteggere dalla recidiva (quali: la terapia di mantenimento, il precedente intervento chirurgico al pancreas, la presenza di masse simil-tumorali circoscritte, il sesso femminile);
- fattori di rischio per la recidiva (coinvolgimento delle vie biliari, coinvolgimento di altri organi oltre al pancreas e presenza di pancreatite acuta o ittero all’esordio).
Sulla base di questo modello, è stato sviluppato un sistema di punteggi (in inglese, score) per classificare i pazienti in base al rischio di recidiva della malattia.
Gli autori hanno così osservato che la terapia di mantenimento preveniva efficacemente le recidive nei pazienti per cui il rischio di recidiva era alto (punteggio maggiore di 155), rispetto ai pazienti con lo stesso rischio che non avevano ricevuto il mantenimento.
Nei pazienti classificati come a basso rischio di recidiva (punteggio minore di 155), invece, la terapia di mantenimento non aveva fatto la differenza rispetto ai pazienti con lo stesso rischio che non avevano ricevuto il mantenimento.
“Questo sistema pone le basi per una valutazione standardizzata del rischio di recidiva della AIP-1 nei pazienti, e quindi per la personalizzazione del trattamento a partire da essa. Difatti, se confermato da ulteriori studi, questo sistema potrebbe in futuro aiutare i medici a misurare il rischio previsto di recidiva nel singolo paziente con pancreatite autoimmune di tipo 1”, commenta il dottor Lanzillotta, primo autore dello studio.
“I medici potranno quindi avvalersi di un criterio oggettivo per guidare la decisione di prescrivere o meno una terapia di mantenimento per i pazienti che presentano rischio alto di ricaduta”, aggiunge il dottor Emanuel Della Torre.
“Ancora una volta, la nostra Unità è in prima fila nella ricerca sulle malattie immuno-mediate come la malattia IgG4-correlata, patologia rara di cui sappiamo tuttora poco. Con il gruppo interdisciplinare che dirigo, siamo impegnati tutti i giorni a comprendere i meccanismi alla base di queste malattie per sviluppare pratiche cliniche volte alla personalizzazione della diagnosi e quindi della terapia sul singolo paziente”, conclude il professor Lorenzo Dagna.